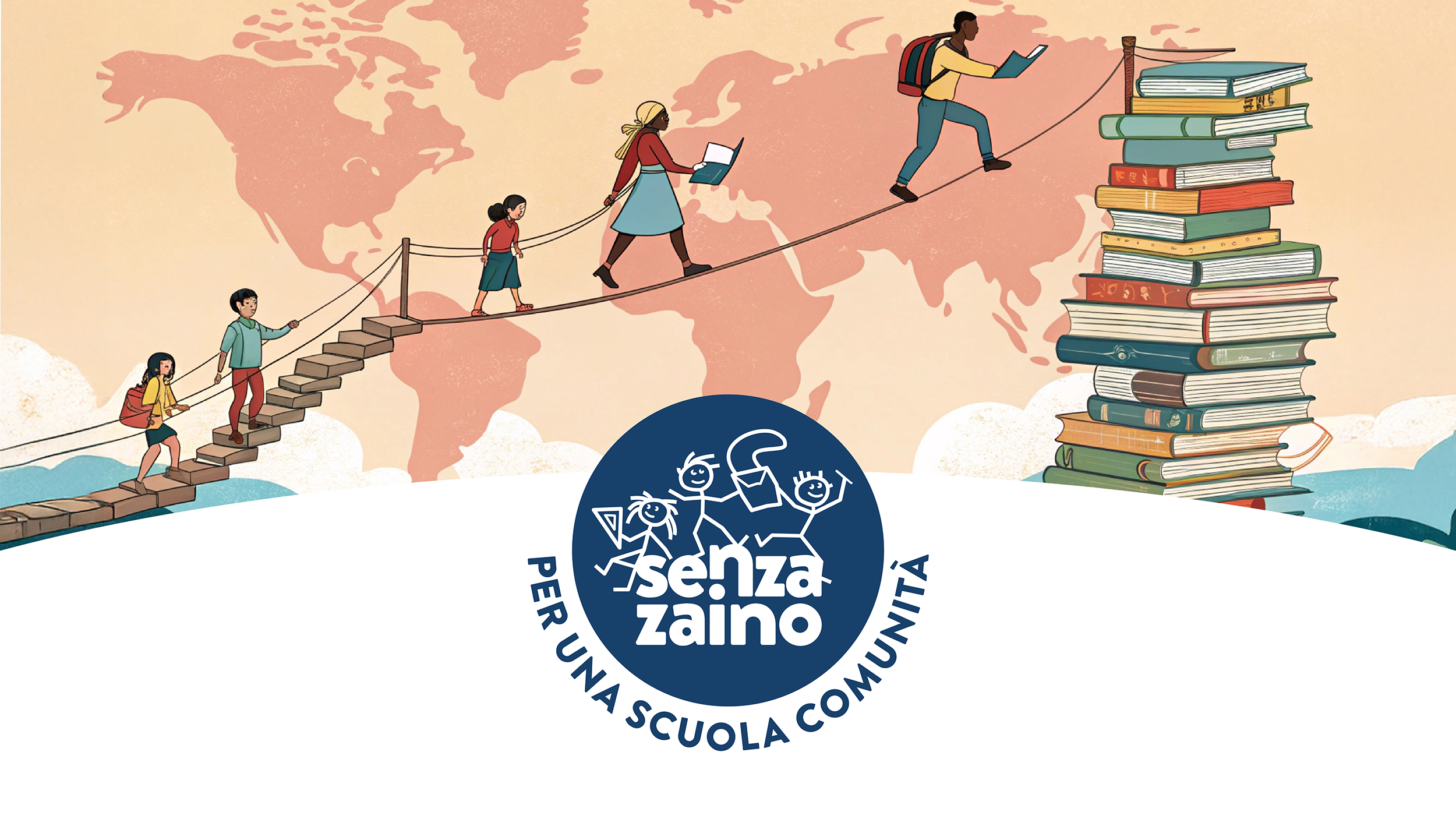
‘Equità nella qualità’ è la frase che mi ha particolarmente colpito nella lettura dei dati Invalsi 2025. Avevo già assistito alla presentazione fatta dall’INVALSI all’inizio del mese di luglio e l’idea che mi ero fatta era quella di un importante miglioramento dei dati rispetto al tema della dispersione scolastica: meno studenti hanno abbandonato la scuola e la percentuale di abbandoni in Italia è inferiore a quella europea, anticipando l’obiettivo fissato dall’Europa per il 2030. Questi dati positivi meritano di essere sottolineati.
Andando però a guardare nello specifico i numeri in ogni ordine di scuola degli apprendimenti di italiano e matematica emerge una fotografia della scuola italiana su cui, a parer mio, è necessario sviluppare delle riflessioni che devono coinvolgere il mondo della politica a livello nazionale, regionale e locale, quello sindacale ed i singoli istituti scolastici che possono essere – insieme agli enti locali – gli artefici di un cambiamento sostanziale di politiche attive per dare risposte concrete e durature nel tempo alle due parole usate dall’Invalsi nella presentazione dei dati. Equità e qualità esprimono concetti a cui devono seguire azioni trasformative radicali su tutto il territorio nazionale.
Quattro sono, a parer mio, i problemi che emergono da quei dati che non riporto in questo testo perchè sono pubblici e di facile consultazione: 1) il divario degli esiti conseguiti nei diversi territori, 2) l’aumento della dispersione implicita, 3) i segnali di indebolimento della scuola primaria, 4) il calo delle eccellenze.
Di fatto il primo macro problema che emerge è sicuramente la differenza negli apprendimenti registrata in ogni ordine di scuola, seppure in maniera diversificata, tra le regioni del nord italia e quelle del sud e delle isole. Divari territoriali che oscillano fra i 18 ed i 23 punti; divari nelle competenze matematiche e di italiano al termine della scuola secondaria di primo grado che ovviamente influenzano anche il proseguimento degli studi di questi ragazzi.
Da cittadina italiana, prima ancora di definirmi persona che si occupa di scuola da più di cinquanta anni, mi domando perchè non è possibile – come appare ancora dai dati dopo un quarto del XXI secolo – dare concretezza all’articolo 3 della nostra legge Costituzionale che recita (e lo trascrivo ancora una volta) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua , di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Dov’è quindi l’equità per migliaia di bambini e ragazzi che vivono in alcune regioni del nostro bel paese? Quali interventi strutturali vengono fatti in quei territori per dare a tutti l’opportunità di acquisire competenze spendibili sul mercato mondiale? Nei documenti Invalsi si fa riferimento ad interventi realizzati con PNRR ed Agenda Sud in alcune regioni come la Puglia, la Basilicata e la Calabria che hanno portato dei miglioramenti sui risultati ma è ancora troppo poco e soprattutto troppo legato ad interventi con finanziamenti altalenanti e non duraturi. La scuola – che è uno dei pilastri fondamentali del sistema paese- ha bisogno di interventi strutturali in connessione con gli enti locali, con il terzo settore se si vuole davvero ridurre i divari territoriali riconoscendo il diritto di ogni bambino , ragazzo e giovane ad una scuola di qualità.
Nei documenti Invalsi si parla dell’importanza degli asili nido, dei poli infanzia, auspicando una sempre maggiore frequenza dei bambini da zero a sei anni: ma quanti ce ne sono in queste regioni, quanti ne vengono costruiti con i soldi del PNRR e come verranno gestiti poi dagli enti locali? A fronte di richieste che vengono anche dal nostro istituto di valutazione nazionale come e cosa rispondono il governo, il ministro dell’istruzione, le varie amministrazioni regionali? I dati Invalsi riguardano gli apprendimenti scolastici e si focalizzano sulle scuole sicuramente con la consapevolezza che la scuola non può rimuovere da sola gli ostacoli sociali, culturali ed economici di un intero territorio.
Oltre ai grafici sulle differenze territoriali mi ha colpito la rilevazione fatta sulla dispersione implicita e la lettura dei dati sulle competenze dei ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado. Per il futuro di questo paese non è accettabile vedere che solo il 54% dei nostri diplomati esce dalla scuola con competenze matematiche a partire dal grado tre (competenza accettabile) ed il 62% con competenze di italiano sempre a partire dal grado tre. E’ evidente che con questi livelli di competenze si sviluppa una dispersione implicita che segna la vita di ogni persona: la ricerca di un lavoro che soddisfi l’individuo, la stessa prosecuzione degli studi a livello universitario, la possibilità di viaggiare sono influenzati dalle scarse competenze acquisite nel percorso scolastico. E qui per me, entra pesantemente in gioco la scuola – complessivamente intesa. Va ripensata completamente la struttura dell’insegnamento che ha bisogno di docenti competenti e quindi debitamente formati a livello di formazione iniziale universitaria e costantemente sorretti da aggiornamenti nel corso degli anni in cui esercitano la loro professione. Formazione obbligatoria, in parte riconosciuta economicamente ed in parte finalizzata all’avanzamento di carriera con crediti formativi spendibili perché di qualità. Docenti però disponibili a confrontarsi, a collaborare, a innovare, a fare ricerca, a costruire insieme al dirigente una visione di scuola partecipata dalla comunità; docenti che favoriscono il protagonismo dei ragazzi nella costruzione del loro percorso di apprendimento perché, solo coniugando impegno e sforzo nello studio al benessere individuale e di gruppo nello stare a scuola, sarà possibile migliorare le competenze dei ragazzi: competenze non solo relative agli apprendimenti disciplinari di italiano, matematica ed inglese ma anche competenze relative ai comportamenti sociali che non possono essere legate al 6 in condotta. La libertà nella responsabilità non si costruisce con una impostazione dogmatica ed autoritaria del fare scuola.
Certo è che questi dati pubblicati dall’Invalsi dovrebbero generare una preoccupazione non solo nella politica ma anche nelle organizzazioni imprenditoriali del nostro paese, nelle famiglie per generare una rivoluzione pacifica di atteggiamenti e comportamenti nei confronti della nostra scuola che continua purtroppo a generare disuguaglianze e povertà educativa. Forse la scuola di qualità auspicata passa anche da scelte radicali da fare tutti insieme.
Il terzo problema su cui mi piacerebbe dibattere è la constatazione da parte dell’Invalsi di un indebolimento della scuola primaria generato dalla presenza di alunni con provenienze diverse. Considerato che la scuola primaria è sempre stata una eccellenza del nostro sistema scolastico, iniziare a segnalare punti di debolezza deve suscitare preoccupazioni ma anche risposte da parte del ministero a livello centrale e sui territori. Sicuramente l’inserimento di bambini che parlano con difficoltà la nostra lingua e devono imparare a leggere e scrivere in italiano rallenta il lavoro didattico tanto più che ci sono classi numerose con numerosi bambini stranieri. Per l’attività che sto facendo in questi anni sto incontrando sempre più classi con una presenza quasi totale di bambini di diversa provenienza e i docenti segnalano le difficoltà iniziali che pian piano vengono superate restando elevato però il divario negli apprendimenti di base.
Ebbene, io penso che a questo problema ci possa essere una risposta immediata e possibile da parte del governo se davvero ci sta a cuore il futuro di questo paese: siamo in anni di calo demografico, si chiudono classi e si perdono nuovi posti di lavoro. Sarebbe logico, e da più parti già richiesto, che gli insegnanti fossero utilizzati per alleggerire il lavoro didattico dentro le classi, per sostenere percorsi personalizzati per ogni bambino e bambina che inizia la scuola primaria. L’Invalsi fra l’altro ci dice che fra la classe seconda e la classe quinta la scuola riesce ad esercitare un effetto di compensazione per quanto parziale.
Investiamo quindi risorse nei primi anni di scuola per dare vere opportunità a tutti di crescere e non fare innescare quei meccanismi, purtroppo già segnalati da diverse realtà scolastiche, che i figli degli italiani vanno ad iscriversi in scuole con minore presenza di stranieri per aver garantita una scuola di qualità migliore.
Anche in questo caso c’è poco rispetto dell’articolo 3 della nostra Costituzione.
Ultimo tema che voglio segnalare emerso dalla mia lettura dei dati è il calo delle eccellenze nelle competenze in particolare di italiano e matematica.
Mi verrebbe da pensare che è un problema didattico risolvibile ad alcune condizioni che provo ad evidenziare e che sono citate anche in alcune frasi del Rapporto Invalsi. Penso però che sia anche un problema sociale perché la società in generale ha bisogno di persone talentuose, che eccellono in alcune discipline e che danno vita a professionalità diversificate, particolari, eccellenti. Queste persone muovono i primi passi nelle istituzioni scolastiche ed affiancate dalle famiglie costruiscono percorsi di vita importanti ed utili per l’intera società del pianeta.
Se le risposte ‘eccellenti’ dei ragazzi cadono e le rilevazioni nazionali mettono in evidenza il problema, dobbiamo in primo luogo chiederci perché e subito dopo come dare risposte al problema. Il rapporto propone alle scuole di arricchire l’offerta formativa, di ampliare le occasioni formative, di differenziare le proposte adottando misure personalizzate a livello di ragazzo, di classe, di scuola.
Detto in poche righe sembrerebbe un problema facilmente risolvibile ma purtroppo non lo è e non lo sarà se non mettiamo davvero mano a questo sistema scolastico burocratizzato che rende difficile anche il lavoro del docente e del dirigente più disponibile e più preparato.
Credo che lo stesso documento sulle Indicazioni nazionali per la scuola di base recentemente approvato dal ministero risponda solo in parte alla direzione indicata dal Rapporto Invalsi. Quale qualità quindi chiediamo alla nostra scuola? Su questi temi sarà necessario continuare a confrontarci.
Prima di chiudere questo mio articolo voglio fare un breve riferimento al lavoro che sto facendo insieme a tante altre persone per rendere la nostra scuola, ad iniziare da quella di base, una scuola equa e di qualità.
Coordino da più di 10 anni la rete nazionale delle scuole Senza Zaino, per una scuola comunità, che ho contribuito a far nascere insieme a molte altre persone oltre 20 anni fa; una rete di più di 800 plessi scolastici distribuiti in ogni regione che condividono una visione di scuola, un modello basato sui valori dell’ospitalità, della responsabilità, della comunità e una quantità di buone pratiche di innovazione didattica e di ricerca fin dall’infanzia. Una comunità di adulti che cerca di rispondere con passione e grande lavoro ad alcuni dei problemi che l’Invalsi mette in evidenza primo fra tutti la differenziazione delle proposte didattiche all’interno della classe per arrivare a percorsi personalizzati in risposta anche ai differenti livelli di apprendimento dei bambini e dei ragazzi.
La strutturazione ‘pensata’ degli spazi scuola, la gestione partecipata delle classi, la progettazione delle proposte culturali che tiene conto delle indicazioni nazionali e di quelle che nascono sui territori, la valutazione formativa degli apprendimenti dei ragazzi che abbiamo definito ‘valutazione mite’, il coinvolgimento delle famiglie e della comunità territoriale, sono azioni faticose ed impegnative che hanno bisogno di attenzione da parte degli enti locali e dell’amministrazione centrale e periferica del ministero dell’istruzione e del merito.
I temi evidenziati in questo ultimo Rapporto dell’Invalsi, nato dalle lettura delle prove somministrate in questo anno 2025, sono complessi e la scuola da sola non può risolverli se non con una partecipazione vera e duratura di tanti soggetti che , con responsabilità differenti, affrontano i due grandi temi dell’equità e della qualità di uno dei servizi più importanti dello stato.
Daniela Pampaloni
Pubblicato il: 23 Settembre 2025
Condividi:
